di Fabrizio Centofanti | 24 giugno 2020
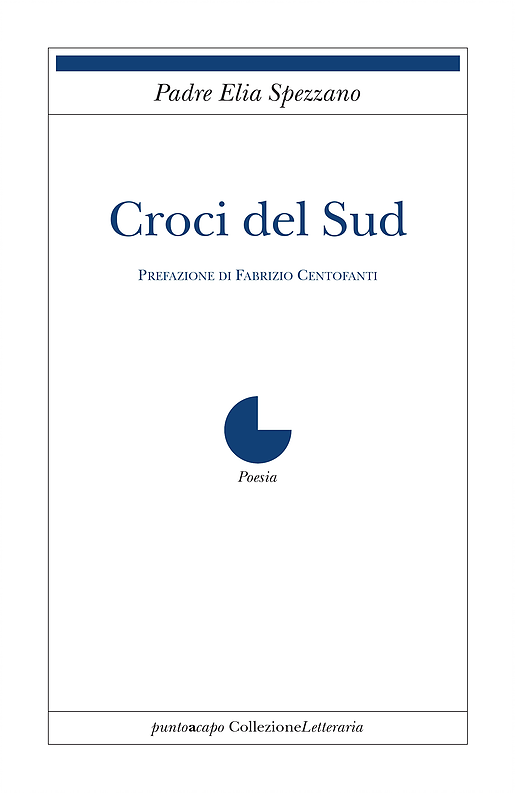
È il libro della musica quello di Sergio Spezzano – in versione monastica padre Elia, con una sorta di duplice profezia di passione e silenzio, secondo il carisma del profeta di Tishbe. Una musica che arriva dove non arriva il cuore, non per mancanza di coraggio, ma per una sorta di – ancora monastica – umiltà. È una porta del cuore che si deve aprire, per vedere le rose di lorchiana memoria, anch’esse segno di sentimenti così radicati da sbocciare.
È una poesia dal caldo respiro quasi latino americano, una via di mezzo tra Lorca e Neruda, immaginazioni in libertà, senza il peso di anacronistiche censure, ma poesia di lotta, canzone da battaglia, a metà strada tra Mosè e gli Intillimani. I versi di Spezzano sono come un Magnificat che non può non ampliare la sua voce, traducendosi in un noi che è al tempo stesso poetico e politico, nel senso della polis, mai abbandonata nell’austero isolamento dell’abbazia cistercense. L’amore, in questi versi, è un valore non solo cristiano, ma incistato nella carne del povero, che è l’uomo tout court, con la sua sempre risorgente, tenera violenza. La contaminazione linguistica è un segnale dell’io che sconfina nell’altro, in una Pasqua interrotta solo temporaneamente dalla morte.
La poesia di padre Elia prende appunto la forma di un inno, ma il Magnificat diventa rosso sangue, nel martirio di chi è vocato in ogni caso a perdere – nell’accezione di un ispirato De Gregori: chi vince è perduto. L’inno diventa un gospel che intona l’elogio della terra – this is my land – l’unica rimasta capace di una gioia genuina, mentre il resto trascolora in un’arida, sterile attesa. La vita residua è una foto, uno scritto mai scritto, almeno a giudicare dal desiderio di andare ancora oltre, in una sorta di incarnazione del sogno. I versi prestano la voce alla Città, che ha modo di sentirsi viva solo a queste condizioni: è la poesia che fa risorgere, perché è stato un Artista a creare tutto ciò che vediamo. Può un monaco non parlare di preghiera? Ma anch’essa si trasforma in rivendicazione sonora e canora, nell’aura di una Kroton mitica che è il centro del mondo, ossia del cuore, l’unica terra del poeta degno del nome. È una falange artistica quella che combatte in una Magna Grecia che non c’è, e per questo solo esiste, nella perenne risurrezione di cui è capace la bellezza. Se la guerra è un sogno è perché la pace è il vero desiderio, ospitato nel monastero del cuore, in una Settima Stanza in cui, sì, risuona la musica che salva. This is my land, direbbe un esiliato della terra promessa o il poeta della terra desolata che è il cuore, combattuto tra la buona battaglia dello pseudo Paolo e lo Shalom dei sogni puri e per questo inconfessabili. È un Messia che si cerca, o è il Messia che cerca ancora l’uomo capace di solidarietà, di superamento di un confine che non è mai sulle mappe del mondo, ma dentro le pareti del cuore. La preghiera cristiana non può essere falsa profezia dei comodi propri: questa non è la mia terra, this is not my land, direbbe il Cristo, a mezza strada tra il Qoelet e Bob Dylan. Ascoltando Whelan o Piazzolla anche le pietre canterebbero, perché la nota lancinante-seducente è in tutto ciò che esiste perché esiste.Sudità è l’essere poesia e preghiera, canto che è al contempo grido di battaglia e annuncio di pace. Calabresità è partorire figli e vederli partire, e partorirli ancora, nonostante, col coraggio del poeta che non scrive mai l’ultimo verso, ma sempre il penultimo. È un discorso infinito, un canto che se smettesse smetterebbe la vita, come il Poeta che è Dio, nel suo sorreggere l’universo con la metrica incalzante dell’agape, che agostinianamente ha il ritmo del cuore più intimo a noi di noi stessi. Come il verso si moltiplica, il cammino dell’uomo è una ricerca senza fine: camminatore è il poeta, un migrante che sempre parte e ritorna: andare e venire, battere e levare, per la stessa ragione del viaggio viaggiare, direbbe un altro instancabile cantore di eroi sconosciuti (di oppressi, di poveri). La poesia di Spezzano è bellezza che si incammina verso la notte del senso, la sofferenza dell’uomo che ogni volta rinasce dalla tomba come musica triste e malinconica, ma così vitale che sembra provenire dalla terra stessa di Dio.
